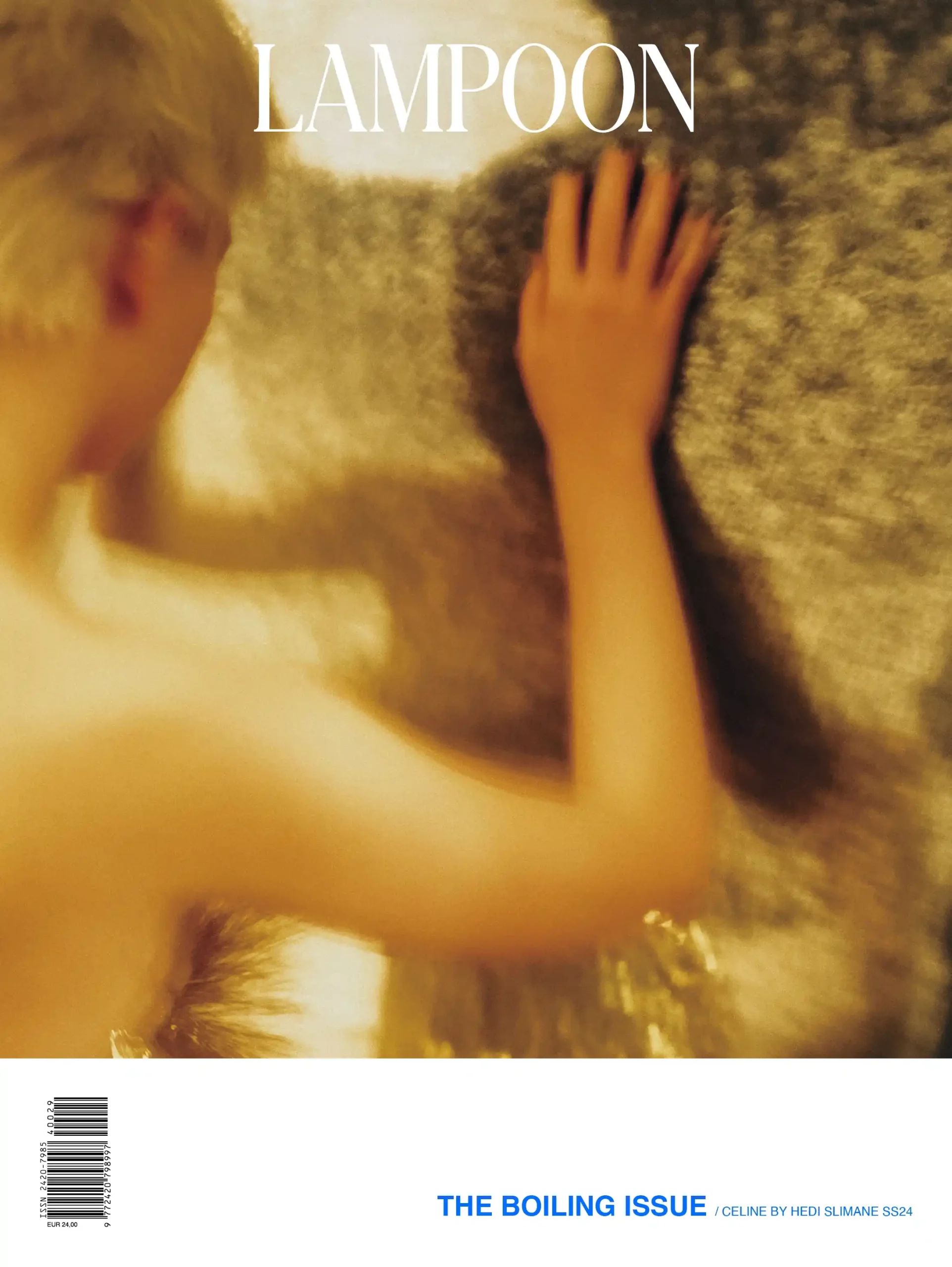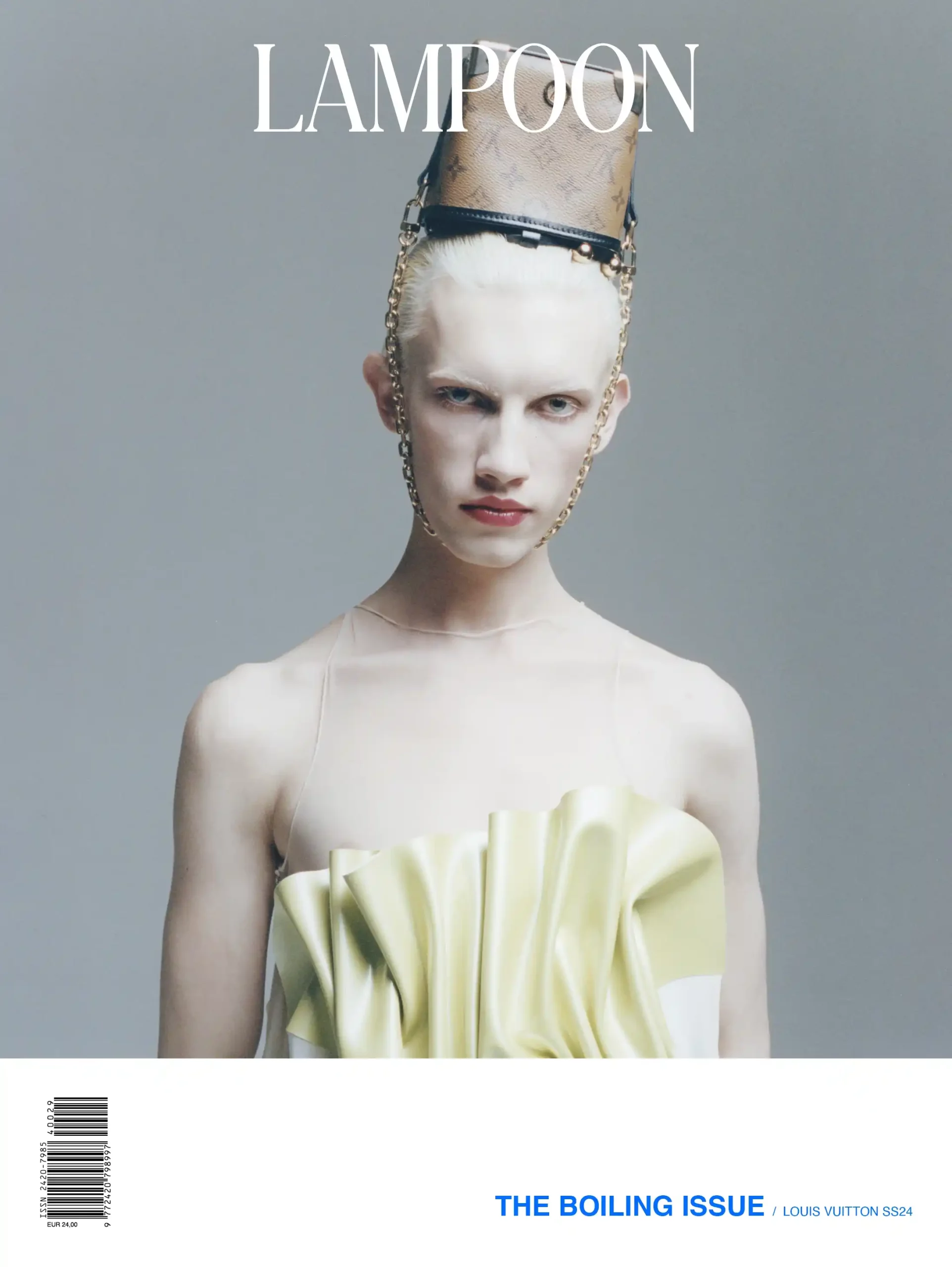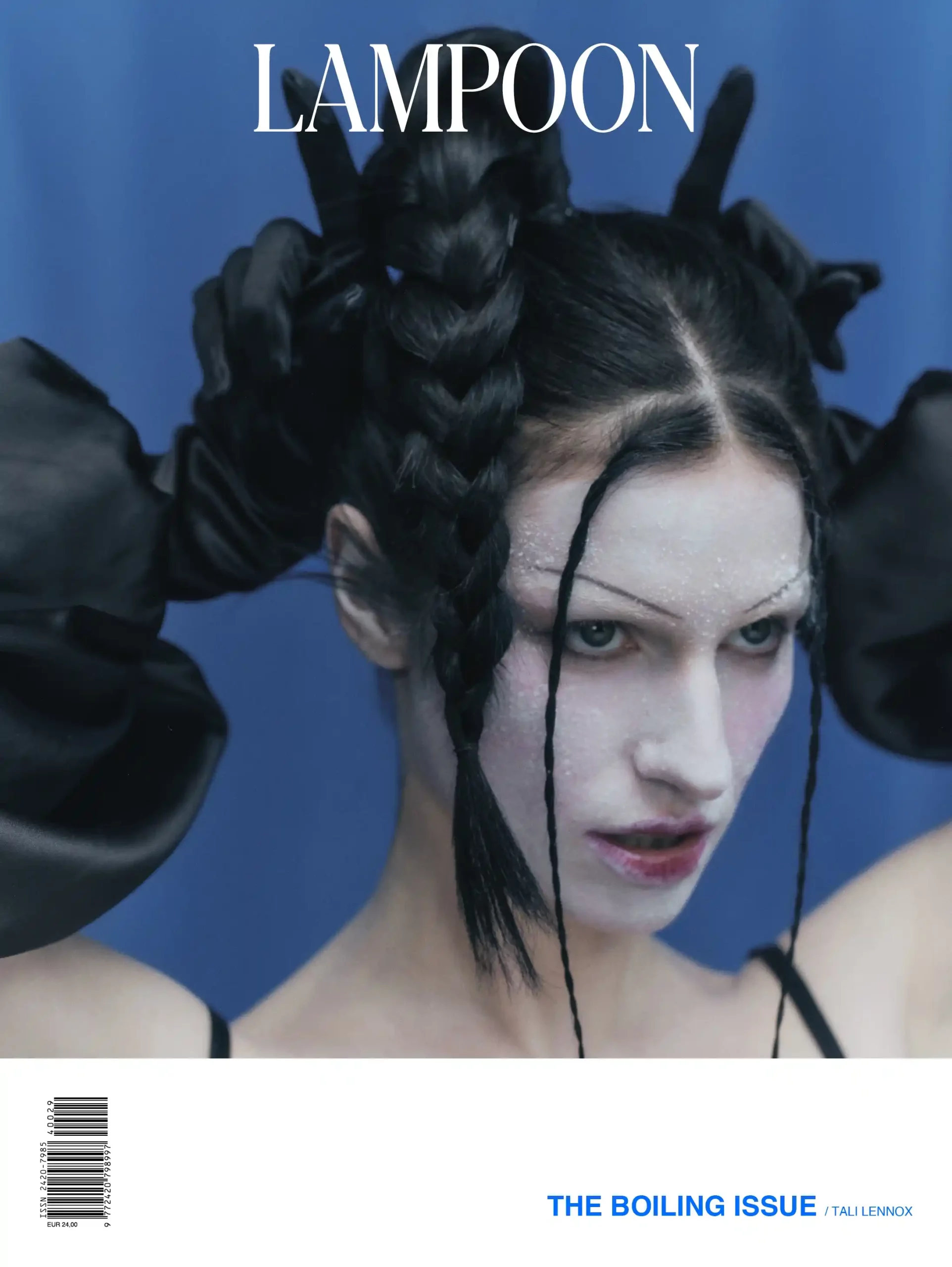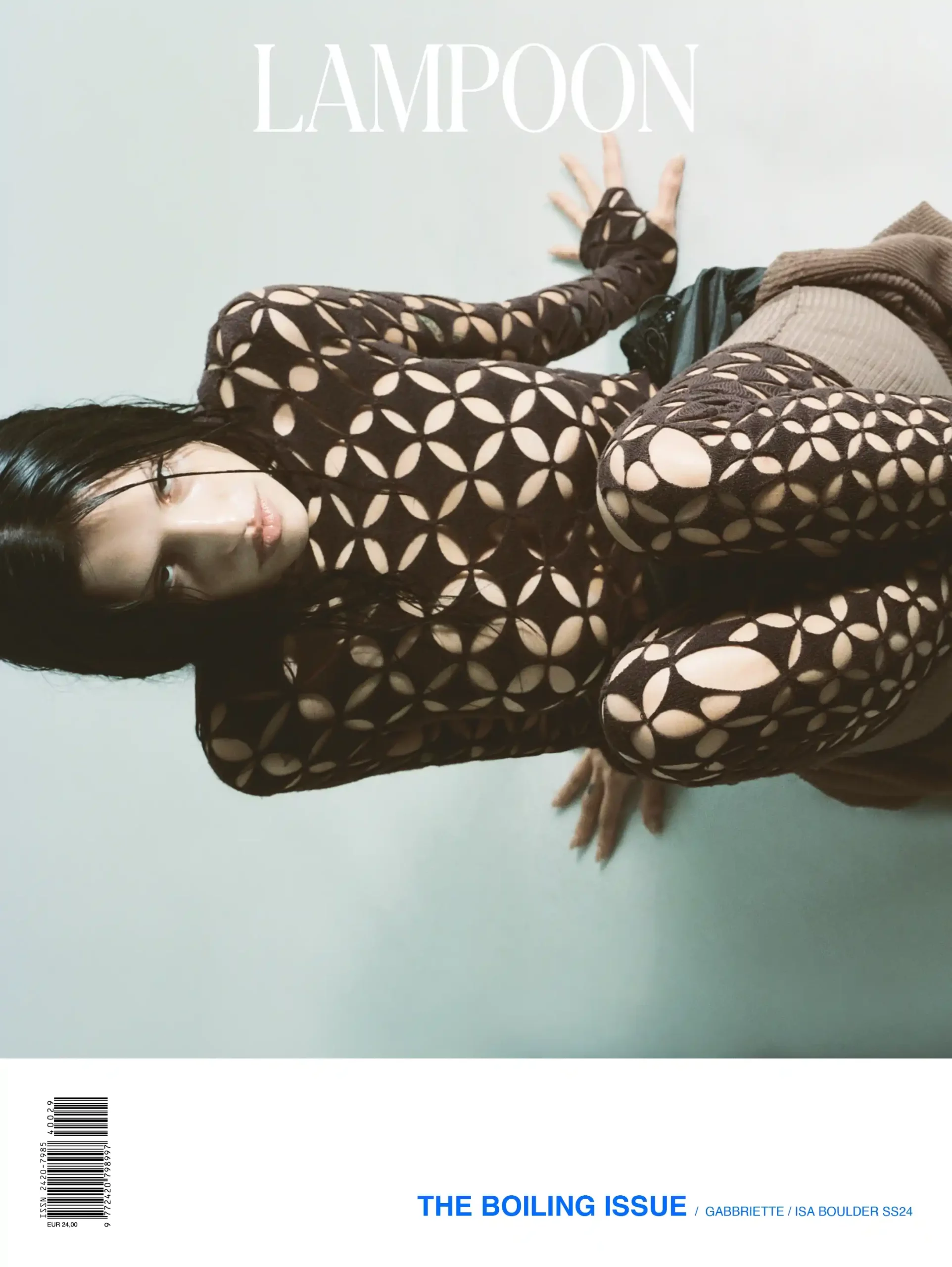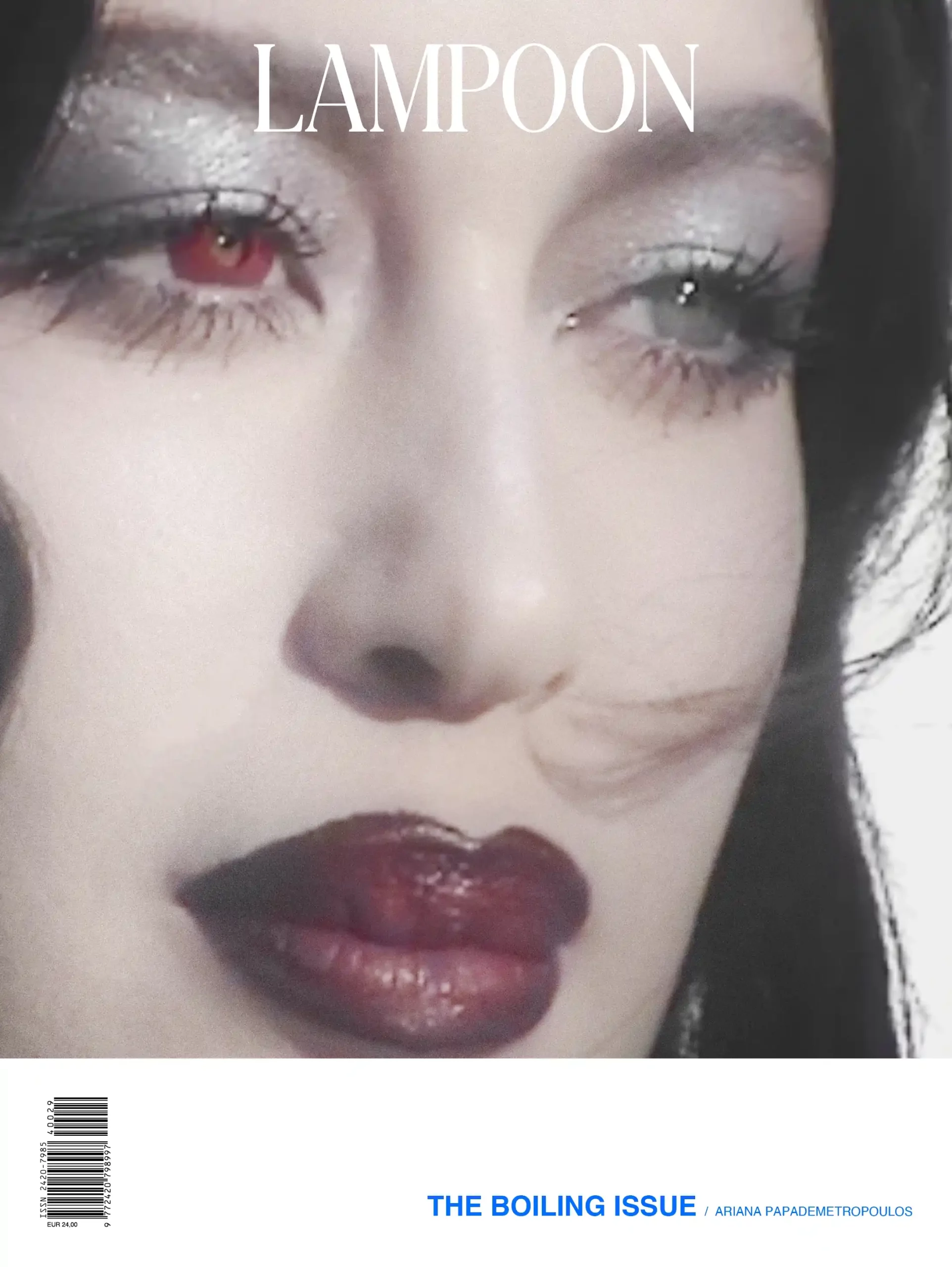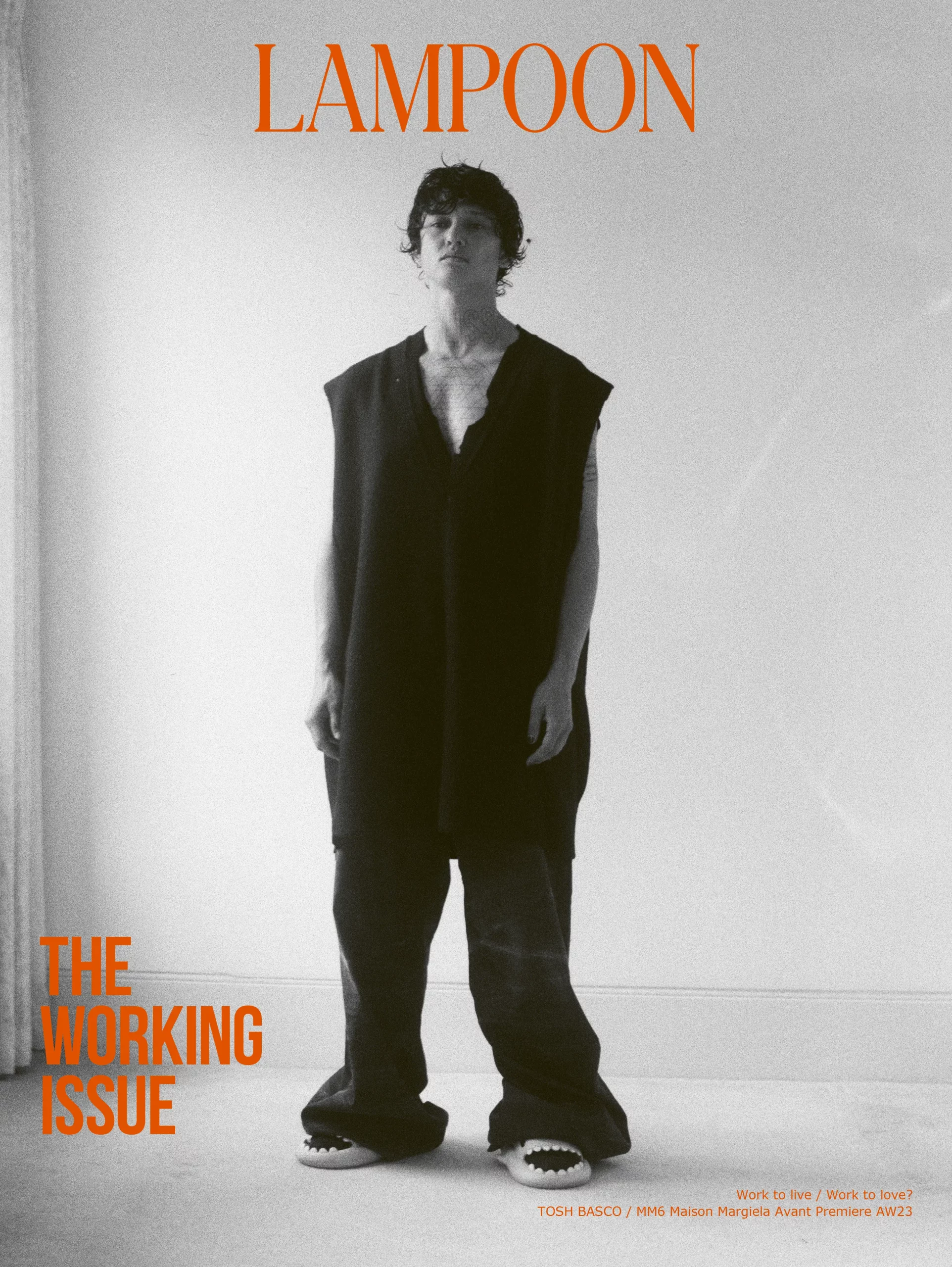«Io non sono mai stato di moda, non ho mai voluto esserlo ed è proprio in quel paese di mezzo che ho conosciuto la mia fortuna» Figurarsi, oggi: «Le vede le sfilate? Roba da pubblico televisivo»
Il Labirinto della Masone accoglie una mostra dedicata a Roberto Capucci
Trent’anni fa, nel 1993, la casa editrice di Franco Maria Ricci dedicò a Roberto Capucci un volume della collana Luxe, calme et volupté, serie di volumi che esploravano il mondo della moda attraverso le opere degli stilisti più affascinanti del Ventesimo secolo. Questa ricorrenza è stata la suggestione per organizzare questa nuova mostra, curatela della Fondazione Roberto Capucci e della Fondazione Franco Maria Ricci con la collaborazione di Sylvia Ferino. La mostra del Labirinto celebra la carriera di Roberto Capucci, affiancando le sue creazioni alle opere d’arte della collezione, creando così dialoghi nuovi e imprevisti, nuove suggestioni che avranno un effetto incredibile.
Un’idea di educazione desueta, con nomi che oramai non fanno più impressione. È una Roma perduta, è un universo altro che ricorda agi non più compatibili con l’oggi, gli appuntamenti dal sarto, le prove-vestito, le première, la guerra per una stoffa. Profumo di cipria alla violetta, passi felpati, voce flebile. «Io non sono mai stato di moda, non ho mai voluto esserlo ed è proprio in quel paese di mezzo che ho conosciuto la mia fortuna. Lì era la mia forza. Le famiglie dell’epoca mai avrebbero gradito vestiti alla moda. Può essere di moda il desiderio di vestire i sogni? È molto di più».
Lampoon intervista Roberto Capucci
Roberto Capucci, piuttosto un architetto del bel vestire che un sarto tout court, è invecchiato disegnando strascichi per le famiglie blasonate, l’aristocrazia nera innanzitutto e da lì il salto tra le nobildonne europee sempre con le forbici in mano e nella mente l’ostinata velleità di reinterpretare il garbo e la bellezza. Forgiato alla scuola romana del sangue blu, avrebbe potuto affrontare qualsiasi altra battaglia e uscirne vincitore. Quella capitolina è coriacea, nei secoli s’è adattata ai papi e agli eretici, l’accento borgataro è un vezzo, il popolo è bene accetto, fa radici antiche. Meno, molto meno, chi tenta la scalata sociale e scalpita nella via di mezzo. Per dire, si gioca a carte col portiere ma non si invita a un pranzo l’avvocato. Finite le ricchezze di una volta, ci si accontenta di quel che resta e si fa di tutto per farlo restare anche se è solo facciata, per qualcuno è la vera sostanza.
Roberto Capucci – un palazzo di famiglia che pone radici lontane nei secoli, non si abbandona
Così fece un principe romano che oramai non possedeva più nulla. A sua disposizione era rimasta solo una cantina, umida e maleodorante, d’inverno riscaldata con una stufa. Gli amici gli suggerirono soluzioni più consone alla salute ma lui no. Nonostante fosse poco più che un antro era pur sempre una pertinenza del suo palazzo, l’indirizzo non cambiava e lui morì sereno così. Raccontava che tornando a casa la sera si compiaceva ad aprire il suo portone, ad attraversare il suo ingresso tutto marmo pregiato. Poi guardava le scale, prese in discesa e non più in salita. Era pur sempre casa. Una storia analoga è ricordata nel film di Paolo Sorrentino La grande bellezza. I nobili decaduti, realmente esistiti e tutt’ora esistenti che si vendevano la presenza a una cena borghese per dare lustro al tavolo. Anche loro resistevano in due stanze ma nel palazzo diventato oramai un museo sfruttato da altri. La sola vista di un posto familiare ma non più tuo avrebbe ucciso qualsiasi nostalgico. Al contrario lo descrivevano come una fonte di dolore, dunque di memento e di vita.
I capelli perfetti di un candore deciso, Capucci ti accoglie in una nuvola di incenso nella sua casa romana che è di per sé un inno al bello, esplosione di sole persino quando stenta, un terrazzo che il maestro ha preteso ricoperto di piante verdi e da fiori, più di trecento. Ci parla e soffre quando accade che qualcuna muoia. Alle spalle di tanta vegetazione colorata, una vista a tutto tondo su una città che lo ama e lo ha amato, lo ha proiettato nell’empireo dei re designer e che adesso il maestro guarda con infinita desolazione. Il primo atelier a vent’anni e a ventisette, la consacrazione in una frase pronunciata come editto dal collega Christian Dior: «Capucci è il miglior creatore della moda italiana». Nato a Roma nel 1930, fa il suo debutto nel 1951 quando partecipa alla prima edizione delle sfilate collettive di moda italiana organizzate a Firenze, realizzando degli abiti per la moglie e le figlie dell’organizzatore. Un successo che non si è mai fermato e che lo ha trasformato in un artista.
Roberto Capucci – i suoi anni migliori, i Cinquanta e i Sessanta
Giusto prima della Dolce Vita, la Hollywood sul Tevere pareva inventata per lui che prese a vestire Gloria Swanson, Isa Miranda, Doris Durante, persino la Monroe così lontana dal suo gusto. In anticipo con i tempi le preferiva magre, eteree, lunghe. Arrivò la principessa Elvina Pallavicini e nulla fu più lo stesso. «Nasceva Medici del Vascello, sposata a una medaglia al valore. Fu vedova che era ancora giovane, donna forte, con grinta, mandò avanti l’azienda di famiglia. Aveva un piglio manageriale. Poco prima di morire lasciò detto a sua figlia di donarmi tutti i suoi vestiti che poi erano miei. Mi occupavo di lei dal 1954, voleva avere un suo stile e facemmo un accordo. Mi dettò regole precise alle quali mi dovevo attenere: molto colore, mai il nero, ‘Lo metto solo in occasione di lutti’, gli abiti da sera sempre con lo strascico, vita sottile, maniche lunghe e girocollo che enfatizza il gioiello e ne aveva di gran pregio».
Fu il lasciapassare perfetto, il viatico per altre nobildonne da interpretare. Perché l’aristocrazia romana sperimenta malvolentieri, s’affida alla persona solo se ne capisce l’indole cauta e malleabile, capace d’adattarsi ai diktat. Pone i suoi paletti e non vuole problemi. Un sarto già sperimentato è una manna dal cielo. Capucci è eletto a couturier delle famiglie di tradizione e di blasone come gli Odescalchi. «Maria Pace era rimasta a capo del castello di Bracciano. Sposata Recchi, altra famiglia importante. Non voleva gioielli pur possedendone, molto magra, si ispirava ai vestiti di mia sorella, abiti da cocktail, non scollati, severi con fantasia». L’atelier di via Sistina diventa meta di pellegrinaggio di madri, figlie, sorelle, mogli, cognate.
Forme architettoniche su colore – il must dei desiderata
«Quando poi si arrivò a ordinare abiti al telefono, la simbiosi parve compiuta. La principessa Isabel Colonna sempre in concorrenza con la principessa Elvina Pallavicini, mai una parola, non osava ma si percepiva. Dovevano andare d’accordo per forza, lo imponeva l’etichetta ma a volte ero in difficoltà. Per gli Sforza Cesarini vestii Leontina per un ricevimento in ambasciata italiana presso il Vaticano. Una volta ho contato quarantasette clienti in un solo salone». Al ballo dei diciotto anni di Inès Theodoli non potevano entrare i divorziati, uomini in cravatta bianca e donne in diadema. Chi non aveva la tiara di famiglia se la faceva prestare. Ai diciotto anni di Maria Camilla Pallavicini intervenne tutta l’aristocrazia romana, austriaca, francese, tedesca.
C’era la principessa Elica del Drago, dama della principessa Pallavicini, tanti cardinali. Elvina era orgogliosa, rigida, contraria alla modernità. Riceveva e accarezzava lo scisma in accordo con Marcel Lefebvre, il vescovo ribelle. «Era tradizione, a Natale, che l’aristocrazia romana andasse in visita ai papi per gli auguri di rito. Dopo tutto quello che era successo, Paolo VI accolse tutti senza slancio, li licenziò e li dispensò in futuro dal tornare al suo cospetto. Nei palazzi fu subito dismessa l’usanza di tenere la poltrona del Papa nella sala dei ricevimenti, per etichetta, di spalle, a guardare il muro dove era appeso il ritratto del Pontefice. A sottolineare il fatto che nessuno avrebbe potuto competere con l’ammirazione di se stessi».
Capucci si perde nei ricordi – brutta bestia, riscaldano e fanno male, carezza e pugno
«Feci l’abito da sposa a Domitilla Ruspoli, nata Salviati, aveva sposato Sforza che tutti chiamavano Lillio. Si lasciarono. Sono rimasto in contatto con Claudia e Giada, le vado a trovare al castello di Vignanello». Che relazione poteva correre tra un designer e la sua cliente altolocata? «Un rapporto di rispetto, mai pettegolezzi. Li detestavano se maturati fuori dai palazzi. Puntuali, gentili a differenza delle ricche che sanno essere solo rigide. Non hanno storia alle spalle».
Una teoria di nomi e di misure, i Nasi, i Cavalletti, il vestito da sposa di Ira Fürstenberg con la madre Clara che non voleva si scegliesse lo stesso couturier delle cugine. «Feci anche un abito da cocktail per Marella Agnelli, la première per sistemare la scollatura le ruppe la collana che indossava. Corsero per tutta la sala prove rubini, smeraldi, diamanti grandi come nocciole. Ho avuto anche una marchesa belga tra le mie clienti. Quando il Met di New York mi ha chiesto il vestito d’angelo d’oro che avevo pensato durante un concerto in Vaticano e che aveva comprato, me lo ha negato. Sarebbe andato alla mostra Heavenly Bodies. Fashion and The Catholic Imagination ma non c’è stato niente da fare. L’ho dovuto replicare. Alla Biennale invece si scandalizzarono, non si chiama un sarto tra gli artisti. Invece mi avevano chiesto dodici vestiti. Erano come sculture, difficili ma unici». Poi a Capucci è andata in sorte anche il premio Nobel Rita Levi Montalcini: «Per l’investitura mi chiese colori caravaggeschi, verde scuro, rubino, viola. Le offrii l’abito, per tutta risposta lei fece un regalo di pari valore alla prima sarta».
Roberto Capucci, se proprio deve eleggere una principessa dei suoi sogni, va a pescare altrove
«Silvana Mangano. Al cinema perdeva molto. La sua raffinatezza era perfetta. Mi raccontò con orrore di Riso Amaro: ‘Provai disgusto per me stessa con quelle forme’. Magrissima, sempre a dieta con le sorelle Natasha e Patrizia che sposò il marchese di San Marzano. Il padre era un ferroviere siciliano ma la madre era inglese e ne aveva ereditato lo stile. Dopo, non ho più vestito attrici. Voglio restare nel sogno di quella donna». Non ha mai cambiato idea. Figurarsi oggi quando impazza l’uso dell’abito prestato. «Una volta Sophia Loren mi disse: ‘Lo dica pure che mi veste’. A me. Figurarsi se le mie clienti s’impressionano della Loren». Figurarsi, oggi: «Le vede le sfilate? Roba da pubblico televisivo».