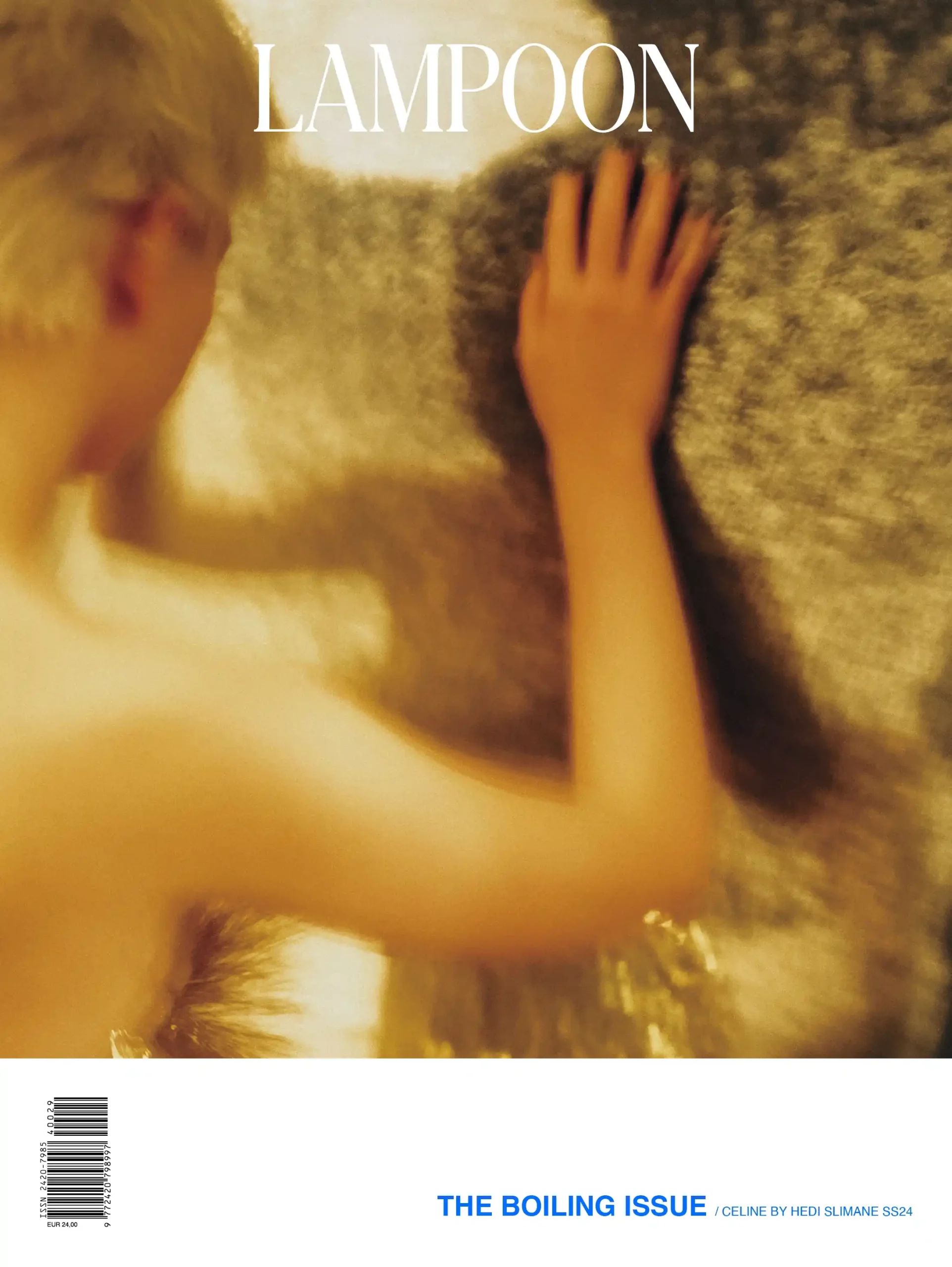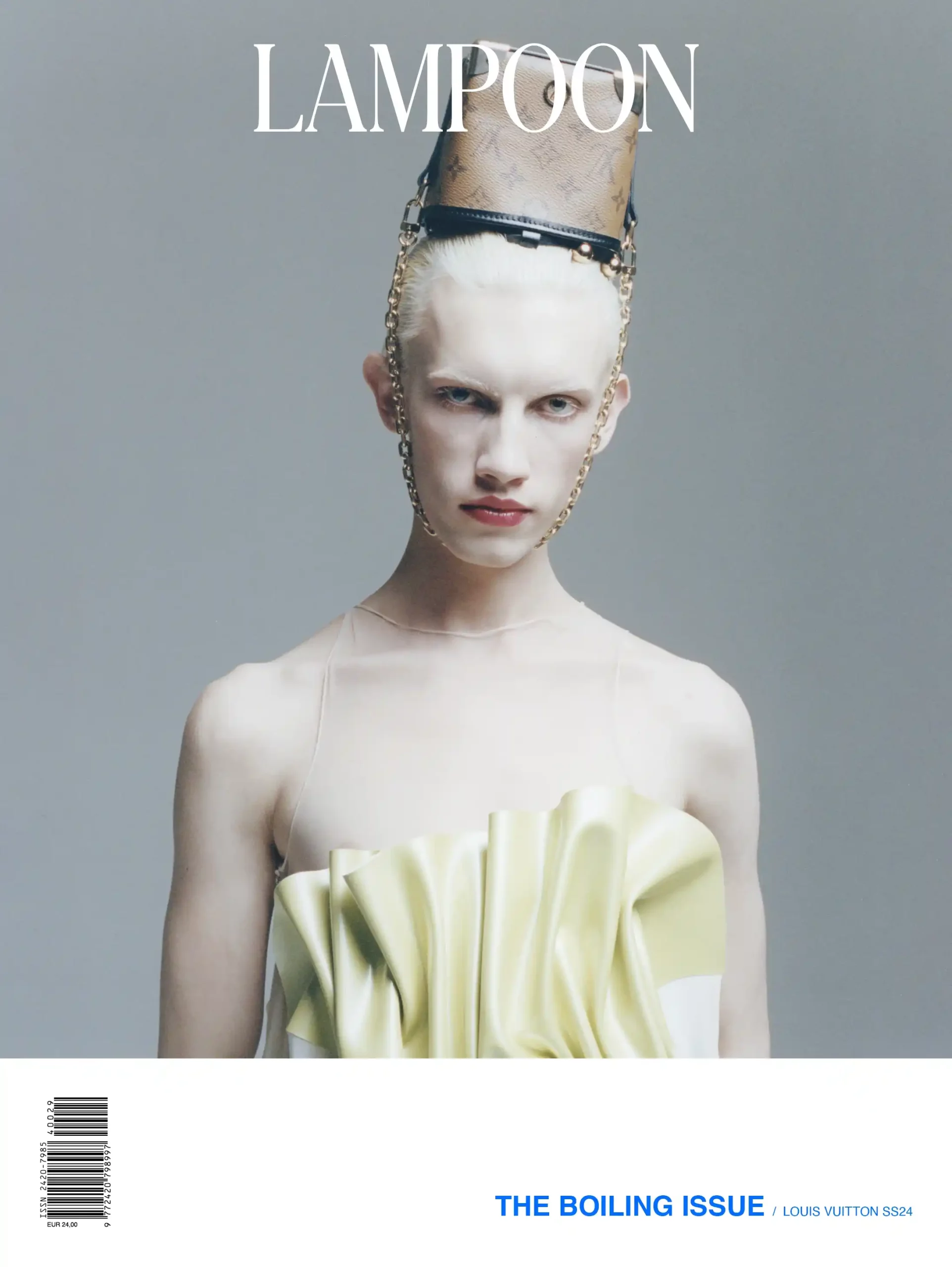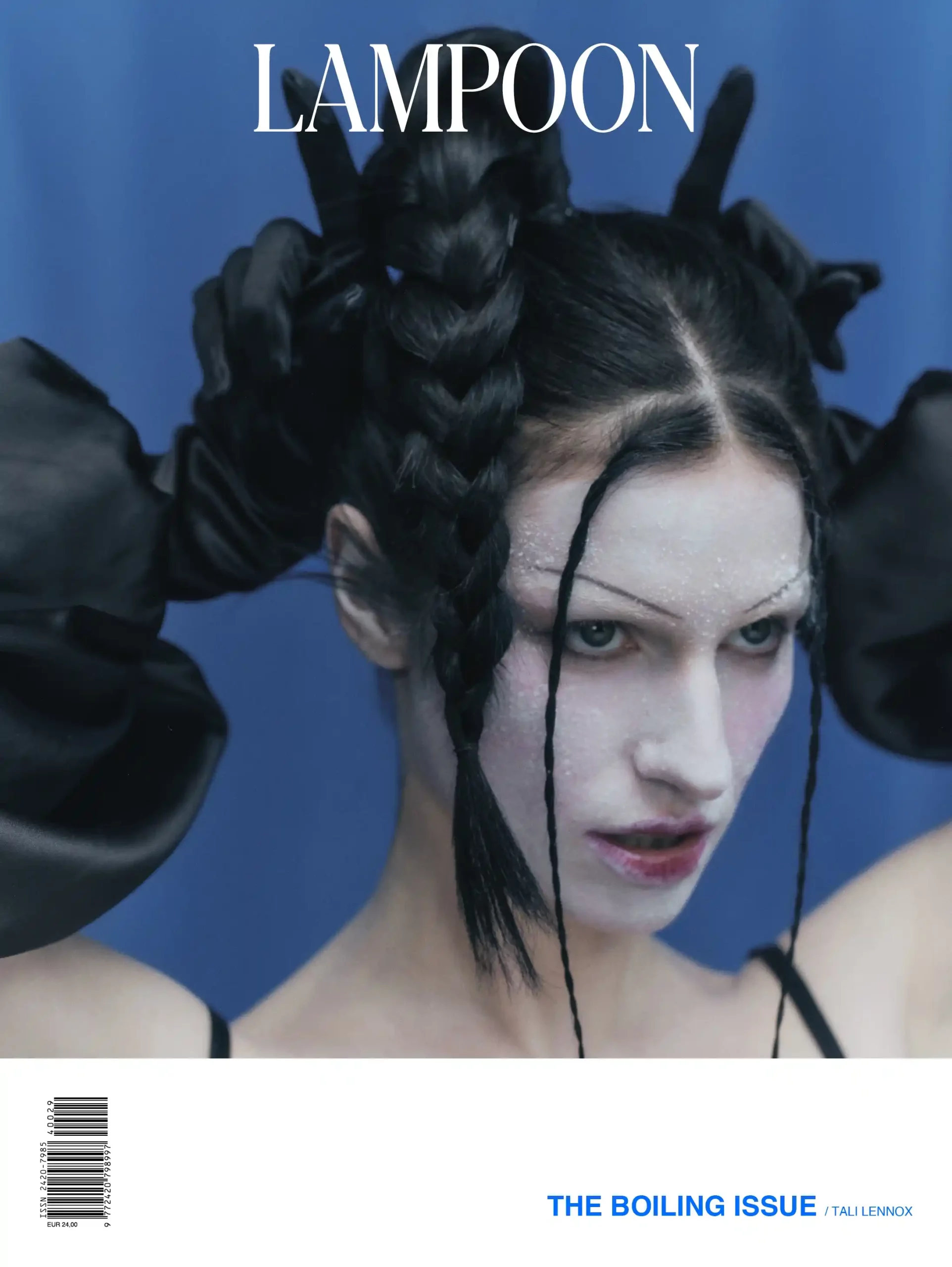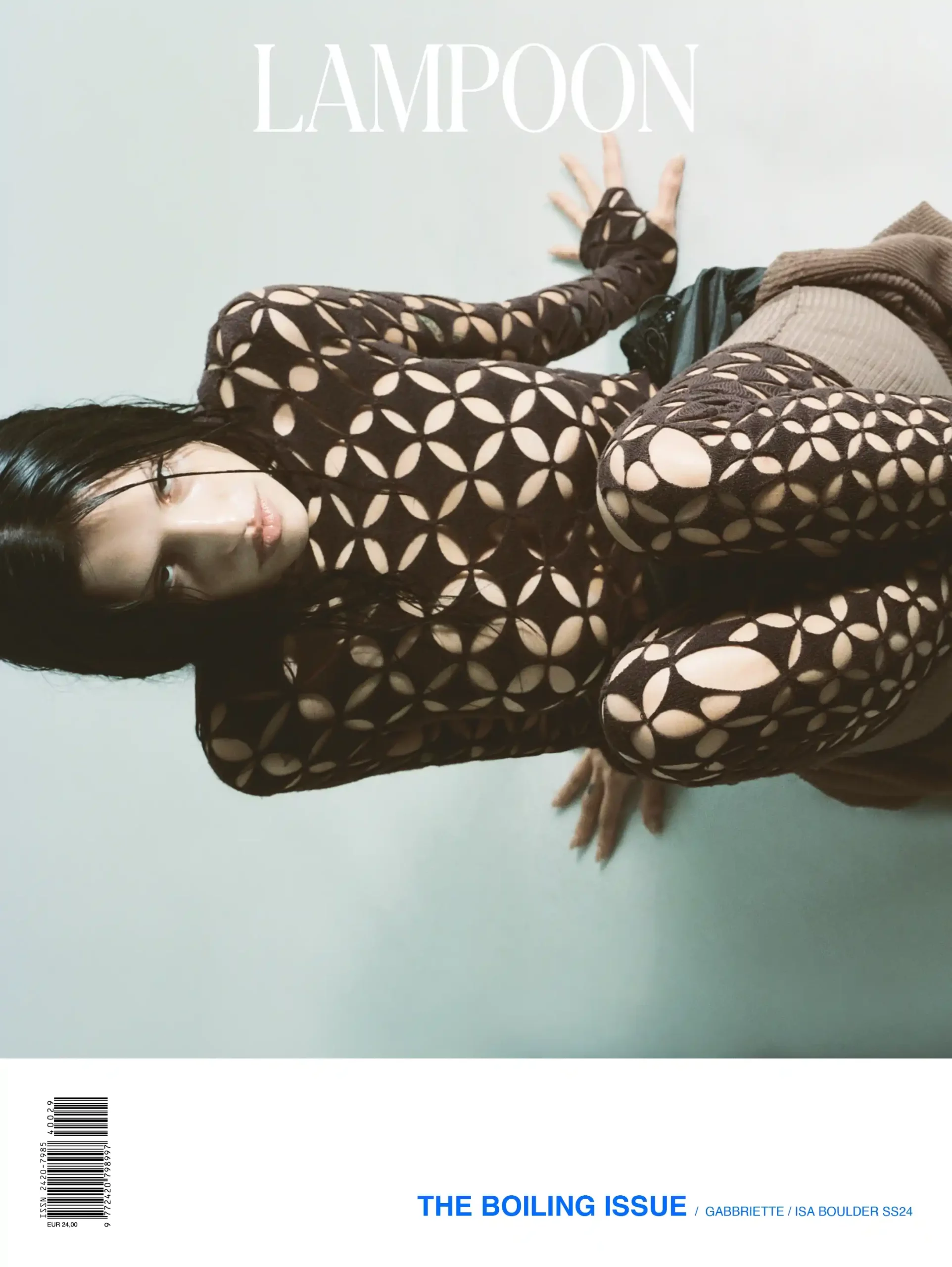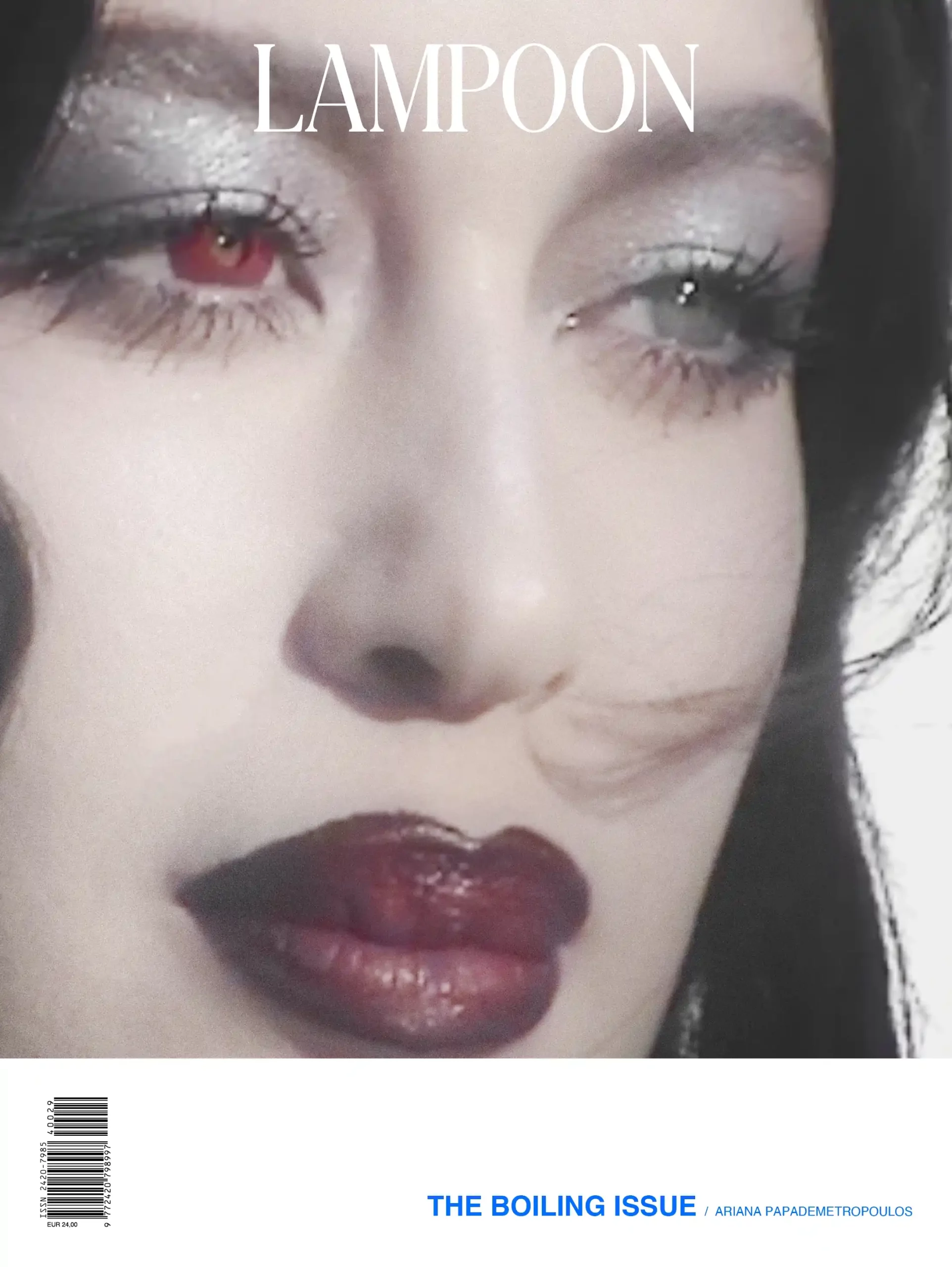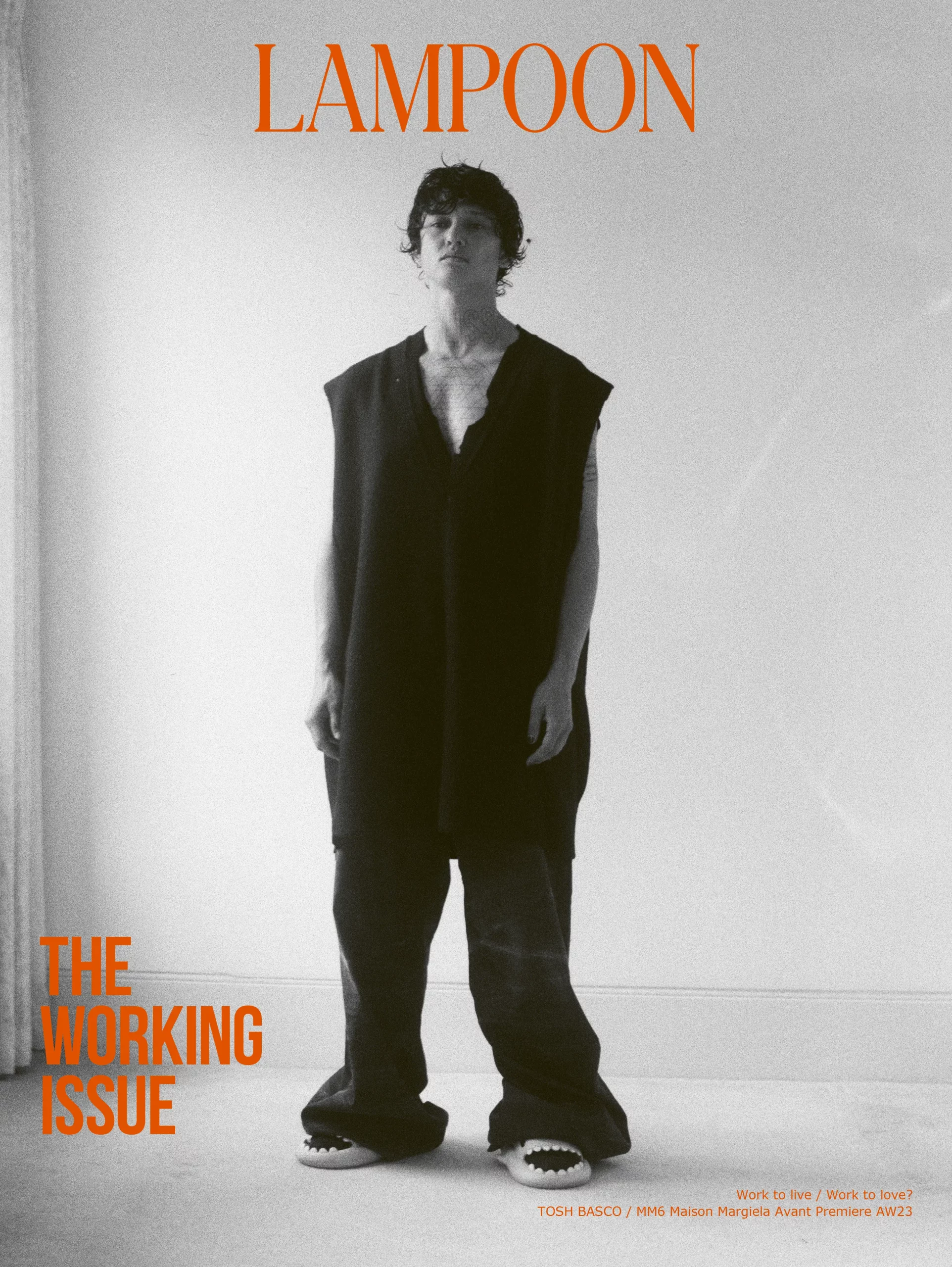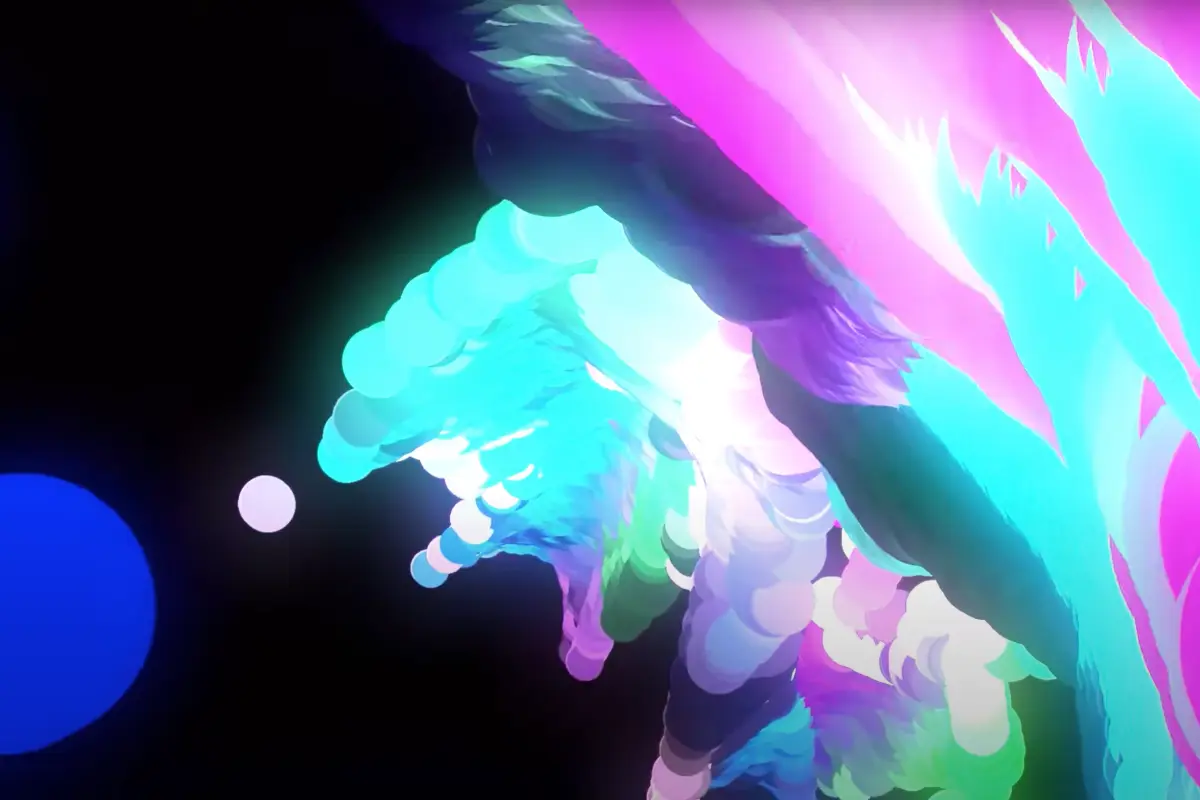Social media, SEO e produzioni cinematografiche: perché il fast fashion è lo strumento per monetizzare la presenza online? – dal caso dei costumi del remake di Mean Girls al discorso del sindaco di New York
Il marketing del fast fashion, dalle campagne social ai costumi delle produzioni cinematografiche – retaggio degli stessi social
Il costumista Tom Broecker ha cercato ispirazione su Instagram e TikTok per il guardaroba delle Mean Girls 2.0. Si tratta della riedizione cinematografica della pellicola che nel 2004 vedeva l’adolescente Cady Heron (Lindsay Lohan) – una ragazza americana che per volontà dei genitori zoologi era stata scolarizzata a casa durante la permanenza famigliare in Kenya – fare il suo ingresso nella scuola superiore di Evanston, nell’Illinois. Quel che segue si può ridurre ad una geografia umana dell’età adolescenziale, fra dinamiche di prepotenza, complessi di emulazione, gerarchie e crisi identitarie. Nella recensione che nel 2004 il critico cinematografico Elvis Mitchell rilasciò sul New York Times il sottotitolo al pezzo era: «Riti tribali di adolescenti che governano con il terrore». Sono trascorsi vent’anni e Mean Girls, già battezzato film cult del genere adolescenziale nel 2004 con tanto di trasposizione in musical a Broadway, rimane una fedele antologia generazionale degli anni Duemila. Un microcosmo di regole di comportamento e di costume politicamente scorrette per sopravvivere al liceo. Tra queste, «Il mercoledì ci vestiamo di rosa» che, nel riadattamento del 2024, suonerebbe «Il mercoledì ci vestiamo Shein».
Uscito nelle sale lo scorso 12 gennaio, il remake di Mean Girls non è una copia carbone del primo: l’oggetto della rappresentazione non sono le dinamiche liceali del 2004, ma quelle del 2024, costumi compresi. Interrogato su cosa ne pensasse del guardaroba delle Mean Girls edizione 2004, il costumista Tom Broecker si è detto contrario alle pratiche di sessualizzazione sui corpi che allora passavano sotto traccia e oggi gridano politically scorrect. Tuttavia, le buone intenzioni di Broecker sembrano fermarsi qui. Difatti, alla domanda sulle ispirazioni per i costumi del remake, l’elenco si limita a Instagram, TikTok e celebrities.
Interrogato su quanto lui e il suo team avessero ricorso al fast fashion, Broecker risponde «Probabilmente più di quanto avremmo dovuto». La sua conoscenza del settore moda e la consapevolezza dell’insostenibilità del modello a rapido consumo – di cui i social sono pieni – hanno impedito a Broecker di inserire pezzi di prima mano di Shein. Tuttavia, non sono mancati capi di Shein di seconda mano. Così facendo, la sua coscienza è rimasta pulita e la fedeltà alle fonti social è rimasta integra. Quello che lo spettatore vede rimane però un capo di fast fashion, intessuto di plastiche non riciclabili, dove la distinzione tra prima e seconda mano è superflua. Ci si chiede come mai un costumista navigato come Tom Broecker abbia bisogno di Instagram e TikTok per cercare ispirazione: non sarebbe stato più naturale porsi il problema educativo di dare agli spettatori ispirazioni diverse, lontane da quello che lo scrolling quotidiano già offre?
Moda non etica: perché il fast fashion è lo strumento ideale per monetizzare la propria presenza sui social?
L’app di Shein è una costante nella classifica delle piattaforme più scaricate, ha un hashtag attivo su TikTok – #sheinhaul – e pare esente dalla crisi che sta colpendo gli e-commerce del lusso – si veda il caso Farfetch, tra gli altri. La strategia commerciale di Shein prevede vertici annuali dove influencer e designer «amici del brand» sono chiamati a creare contenuti adv. Durante l’ultimo summit di Los Angeles Shein si è presentato come un modello di business redditizio fondato su innovazione, diversità e inclusione. A dare concretezza alla pretesa di diversità dell’azienda erano presenti stand dedicati a temi di bellezza, moda e sostenibilità con membri della community di Shein di diverso background culturale. Un’ipocrisia ben camuffata, come ha sottolineato la professoressa del Fashion Institute of Technology Shawn Grain Carter, la quale ha sintetizzato il diversity claim di Shein in «Quello che vogliono è fare più soldi, e ora si stanno accorgendo di come un bacino più diversificato generi milioni se non miliardi di margini di profitto. Non si tratta di un impegno altruistico. Questo è un impegno finanziario».
La strategia commerciale di Shein ha trovato terreno fertile sui social media, dove il fast fashion è uno mezzo per monetizzare la propria presenza su Instagram e TikTok. Per chi ha familiarità con i social media, la pervasività del brand è evidente. La situazione peggiora se si rientra nel target demografico del marchio: ragazza sui vent’anni, attiva sui social e con una consistente cronologia di shopping online. A quel punto, l’algoritmo, alimentato dai dati personali che Google trasmette ai brand, vi indirizzerà a pubblicità sponsorizzate, video di influencer che mostrano soddisfatte i loro acquisti e suggerimenti targettizzati. L’ubiquità di Shein copre oltre duecento paesi in tutto il mondo, contando sugli Stati Uniti come principale mercato. Nel 2021 l’app del marchio ha superato per la prima volta le vendite del colosso Amazon negli Stati Uniti, un primato che fino a quel momento nessuno era stato in grado di scalfire. Dal 2012 il fatturato è cresciuto costantemente, con una netta accelerata nel periodo pandemico, quando ha toccato per la prima volta i dieci miliardi.
Il marketing di Shein non guarda alla fascia «ricchi e famosi»
Seconda la società di analisi informatica Similarweb, Shein è uno dei marchi più taggati e ripostati, con una presenza social delle più rilevanti. Benché si possano citare collaborazioni con celebrità internazionali come Katy Perry e Nick Jonas, il marketing di Shein non guarda alla fascia «ricchi e famosi». La sua reputazione si fonda piuttosto su giovani tiktoker e instagrammer che vedono nel fast fashion una via facile e veloce per monetizzare la propria presenza sui social.
Il modello di business di Shein è basato su quantità e velocità. Ogni settimana mille nuovi capi fanno la loro comparsa sul sito: un eccesso di produzione che può essere reso accessibile solo da prezzi inspiegabilmente bassi per il consumatore, e altissimi costi etico-ambientali. Si possono trovare facilmente magliette a meno di sei euro e vestiti a meno di dieci, supportati da suggerimenti di aiutanti digitali. In quanto a marketing il tutto funziona, con ripercussioni positive sui termini legati al fast fashion in ottica SEO. E così spiega anche l’inserimento di Shein – ma anche di Cider, Princess Polly, PrettyLittleThing e simili – in produzioni a target giovane come il remake di Mean Girls.
Fast Fashion: un mondo online senza necessità di filiera produttiva. Il caso del «finto negozio» di PrettyLittleThing
L’emergere di Shein come colosso del fast fashion, con una valutazione di mercato di cento miliardi – per intenderci, quanto la somma di H&M e Zara – non si deve solamente ai prezzi concorrenziali. Shein vive solamente online: non esistono negozi fisici, ma solo sporadici pop-up ed eventi dedicati al rafforzamento della community – anche questa online. Non investendo in spazi fisici e personale addetto alle vendite, i margini di guadagno aumentano, e così si spiegano i cento miliardi. La parola chiave è filiera, o meglio, assenza di filiera. Se per filiera produttiva si intende la catena di passaggi che porta la merce dal produttore al consumatore, Shein e marchi affiliati ne sono privi. I capi lanciati giornalmente sul sito vengono spediti direttamente a casa dell’acquirente, senza rischi di intoppi nella catena di approvvigionamento e costi aggiuntivi come i dazi di importazione. Se a questo aggiungiamo una manodopera sottopagata e materiali sintetici, l’equazione è presto fatta.
Un aneddoto sulla questione è raccontato sul The Atlantic dalla giornalista Rachel Monroe in merito al «finto negozio» di PrettyLittleThing. Il marchio, fondato nel 2012, è, accanto a Shein, uno dei più popolari nel mondo del fast fashion e, proprio come Shein, vive unicamente online. Sulla Melrose Avenue di West Hollywood si trova tuttavia uno showroom del brand: uno spazio rosa, con due unicorni alati sulle porte, un divano in peluche, una finta cabina telefonica e relle ricolme di vestiti senza prezzo. Lo scopo dello showroom non è la vendita – non si può per questo parlare di negozio – quanto la promozione. La clientela dello showroom è infatti composta unicamente da influencer affiliati al marchio, che ogni due settimane possono prendere appuntamento per una visita. Quest’ultima consiste nel provare nuovi capi, selezionarne alcuni da portare a casa come gift e scattare qualche immagine Instagram friendly.
Chi prende posizione per chi non lo fa? Il discorso del sindaco di New York Eric Adams sul pericolo dei social media
Se il costumista di Mean Girls Tom Broecker non si è posto il problema educativo, altri l’hanno fatto. Tra questi, a saltare agli onori delle ultime cronache è stato il sindaco di New York Eric Adams, il quale ha attivato una vera e propria campagna contro le piattaforme social. Il loro uso strumentale ai fini di marketing che Adams definisce pericolosi, come quello del fast fashion, si traduce, sempre a detta del primo cittadino di New York, in diseducazione. Durante il discorso annuale in merito allo State of the City Adams ha dichiarato «Così come è stato fatto con il tabacco e le pistole, tratteremo i social come un altro pericolo per la salute pubblica». Altrove, ha bollato i social media come una «tossina ambientale» e «un pericolo per la salute pubblica». Si tratta del primo caso di una presa di posizione tanto forte contro le Big Tech, le quali sono state accusate di guadagnare alle spese della salute dei consumatori. Per ora, le misure pratiche anticipate da Adams non sono state rese note, ma, considerando che gli Stati Uniti rappresentano il principale bacino di consumatori del fast fashion, ci si aspettano ripercussioni su tutti i settori che gravitano attorno all’online.
Benvenuti nel mondo del fast fashion
«Il ballo di primavera è fra due settimane, e una mia amica ha bisogno di aiuto per scegliere l’abito. Mi invita a guardare il suo telefono, dove un mosaico infinito di abiti eleganti, nessuno sopra i venti dollari, si muove davanti ai miei occhi. Dopo una lunga riflessione, decide per un abito color zaffiro brillante con dettagli plissettati che ricoprono il corpetto. Altre due settimane, e l’abito, indossato solo una volta, tappezza il fondo di una discarica. Benvenuti nel mondo del fast fashion».
Evelyn Wang, diciassette anni, è tra le vincitrici dello Student Editorial Contest lanciato dal New York Times nel 2022. Quanto descritto da Evelyn Wang potrebbe essere parte di un copione cinematografico sul genere del remake di Mean Girls, uscito nelle sale lo scorso 12 gennaio. L’affermazione del costumista Tom Broecker secondo cui avrebbe guardato alle tendenze di moda giovanili per i costumi del nuovo Mean Girls è così avvalorata.